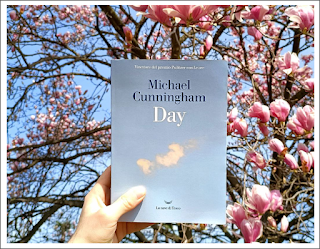Lanthimos,
visionario, sorprende anche per tempismo: il suo ultimo film è il
lato oscuro di Barbie.
Orgiastico e stordente, racconta le avventure di una creatura in
polemica con il suo creatore: passerà da un padrone all'altro
per conoscere il sapore delle ostriche, degli umori corporei, del
sangue. Al regista greco
si può sì rimproverare una parte centrale ridondante, scarso equilibrio
(a differenza che in La
favorita,
insuperato), ma la sua Bella zoppica prima di imparare a danzare. La
interpreta una Stone senza vergogna, che trasforma il suo corpo in un
bignami di tutti gli stadi dell'evoluzione umana e di tutti gli studi
di genere. Deliziosamente blasfema (è Madre, Figlio e Spirito), fa
fiorire nei personaggi maschili emozioni sconosciute – la tenerezza
in Dafoe, la gelosia in Ruffalo – e diffonde la buona novella
intrisa di positivismo. Il suo ritorno alla vita è un inno alla
gioia spoglio di retorica, che semina scompiglio fra i
perbenisti. Ma l'indimenticabile Baxter, che imparerà presto a non
masturbarsi a tavola, a non sputare il cibo sgradito, a non parlare
di sesso in pubblico, è una provocatrice schierata contro i mulini a
vento dei costrutti sociali. Guicciardini scriveva: “Lo ingegno più
che mediocre è dato agli uomini per loro tormento”. E alle donne?
L'esperimento che sperimenta ha testa, cuore e clitoride. (8)

“Urgente”,
“necessario”, “importante”. Lo hanno commentato tutti, e tutti con gli stessi aggettivi. Lo sapete: è il dramma
sull'Olocausto che non mostra mai i campi di concentramento, ma la banalità delle famiglie naziste. Lo sapete: in casa Hoss, un paradiso da proteggere, poco importano le urla, gli
strepiti, i pianti che cozzano contro il nitore della fotografia;
poco importano le piogge di ceneri. Il turbamento dello spettatore
nasce proprio lì: dalla freddezza glaciale dei lunghi quadretti
domestici; dallo scollamento tra immagine e sonoro. Sperimentale,
l'ultimo Glazer si poggia su un'idea vincente. Per quanto stimolante,
però, non è un film che ho sentito visceralmente. L'estetica,
fulgida, ne fa un'asfittica camera ardente. L'approccio, nuovo, non
basta a reggere l'intera visione. I protagonisti, inquadrati in campo
lungo, si muovono come i concorrenti di un reality. Resto
un amante del cinema narrativo. E La
zona di interesse
racconta una storia bruttissima, restando per tutto il tempo su una
soglia che – se non concettualmente – non ha suscitato interesse. Esporci agli orrori senza filtri, senza morale: ci renderà
sempre più saggi o più assuefatti? Vincerà, ma non è il "mio" Miglior Film. (7)

A
vent'anni di distanza dal loro ultimo incontro, una vecchia coppia si dà appuntamento. A New York parleranno di scelte,
seconde possibilità, predestinazione. Pacata presa
di coscienza, in cui tra le righe si riflette anche
di ambizione femminile e identità culturale, Past
Lives
si inserisce nel filone delle romcom indie. Impossibile non
pensare a Linklater, Coppola, Kar-Wai. Immancabili le
lunghe carrellate, una città da cartolina, i silenzi riempiti dalla
densità di certi sguardi. La regia è una carezza; i protagonisti,
dotati di una chimica incantevole, animano un triangolo dagli esiti
piuttosto prevedibili. Ma a rimanere impresso è soprattutto il
marito di lei, tagliato fuori dai dialoghi dei due innamorati
ritrovati; incapace di decifrare i sogni della moglie immigrata e,
per questo, inconsolabile. Agrodolce e discreta, Song non osa
variazioni sul tema e regala ai romantici tutto ciò che si
aspettavano. Volutamente algida, confeziona un film (per qualcuno già
cult), forse più fortunato che bello. Past
Lives è
un ordinario esordio da Sundance che gode di una vetrina
straordinaria: gli Oscar. Si ha, tuttavia, la sensazione di averlo
già visto altrove. Magari in un'altra vita?
(7)

Uno
scrittore afroamericano incappa sempre nel solito rimprovero: non
scrive storie abbastanza nere. Gli editori, bianchi, bramano vicende
di tossicodipendenza, criminalità, sbirri violenti: tutto pur di
sgravarsi la coscienza e alimentare il cliché. Per scherzo, il
protagonista scrive un guazzabuglio di luoghi comuni. Il romanzo
diventerà prima un bestseller. Diciamolo: candidato a cinque Oscar,
American Fiction avrebbe meritato soltanto una nomination per
la sceneggiatura. Già premiato al Sundance, non brilla per fattura,
ma è un'inaspettata ventata d'aria fresca. Originale, divertente,
leggero ma non troppo, è una provocazione intellettuale che scardina
i meccanismi dei successi editoriali e dei premi letterari.
Nonostante le premesse memorabili, il potenziale del tema non viene
pienamente sfruttato. Le pieghe pirandelliane vengono talora messe in
secondo piano dalle vicende familiari del protagonista; la satira
viene stemperata dall'Alzheimer di una mamma anziana, dal coming out
del tormentato Sterling K. Brown, da un matrimonio e un funerale. Ma
si ride, e di noi. Quante volte abbiamo definito un romanzo
“coraggioso”? Quante volte abbiamo fatto ridere sotto i baffi
qualcuno come Jeffrey Wright, qui diviso tra orgoglio e denaro? (6,5)

Tratto
da una storia vera nerissima, è il film più impegnativo tra i
candidati. Con le sue oltre tre ore di durata, è un atto d'accusa
contro gli abusi dei bianchi a danno dei nativi. L'indignazione e lo
sgomento vengono soffocati dai ritmi dilatatissimi e dall'andamento
prevedibile; la piega giudiziaria dell'ora finale, in particolare,
annoia e affatica. Leonardo DiCaprio, imbelle, si lascia traviare da
un'eminenza grigia con il ghigno di Robert De Niro. Teatrali e
gigioneggianti, finiscono per mettere in ombra Lily Gladstone: una mater
dolorosa sobria e piena di contegno la cui recitazione misurata,
lontanissima da quella grandattoriale del duo, appare piatta al
confronto. Dirige Martin Scorsese: la storia del cinema in persona. Ma il
cinema è anche andato avanti. E questo classico western di denuncia,
con il solito classico Scorsese alla macchina da presa, mostra un
regista ormai fermo alla stessa impostazione rigorosa, ai soliti
attori virtuosi, alle stesse storie solenni. Lo si candida per
rispetto reverenziale. Ma pochi vedranno questa sua ultima fatica
film fino alla fine. (5)